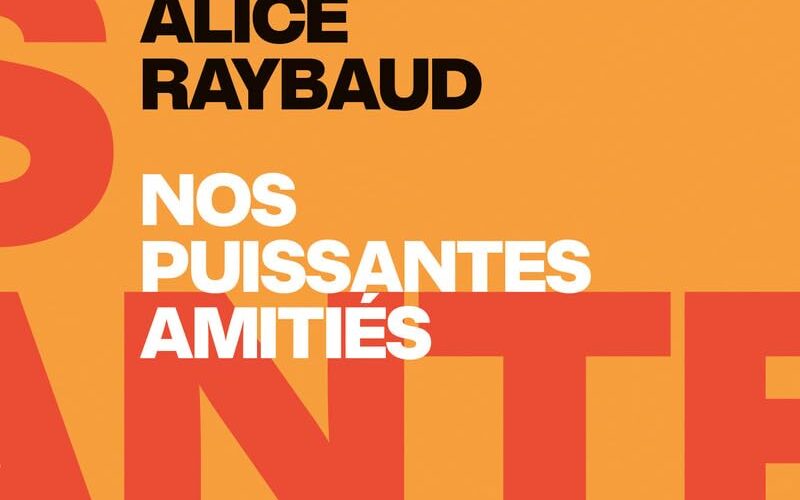Il linguaggio ha però sempre avuto questa porosità. In un articolo universitario, lo specialista dell’Antico Testamento Thomas Römer ricorda che l’ebraico biblico non faceva distinzione tra «amore» e «amicizia»: «Per descrivere queste due relazioni, utilizza la radice ‘ahab. […] Non esiste alcun termine specifico per designare l’amicizia o l’amico.» Nell’Antichità greca, l’espressione dell’amore si dice in almeno otto maniere differenti. Si trova l’«eros», o l’amore erotico, la «philia», o l’amore affettuoso (quello che si associa oggi alla nostra definizione dell’amicizia, ma che era una forma d’amore a pieno titolo), «storgê» o l’amore familiare, e «pragma» che indica l’amore duraturo (quello che è maturato, che possiamo ritrovare nelle coppie sposate da molto tempo, o nelle amicizie molto lunghe). Ma anche «ludus», l’amore giocoso (quello dei primi turbamenti, dei flirt o della frivolezza festosa), «mania» o l’amore ossessivo, «philautia» o l’amore proprio, (che può corrispondere a un’autostima sana, necessaria per amare gli altri), e infine «agape», l’amore disinteressato, quello dell’altruismo o dell’amore spirituale. Secondo i momenti della nostra vita e le relazioni che si intrattenne, possiamo assolutamente ritrovarci a cavallo tra diverse di esse. Uscire dalla binarietà ci permetterebbe quindi di riconoscere l’amore lì dove si dispiega, di trovarcene più ricchi.